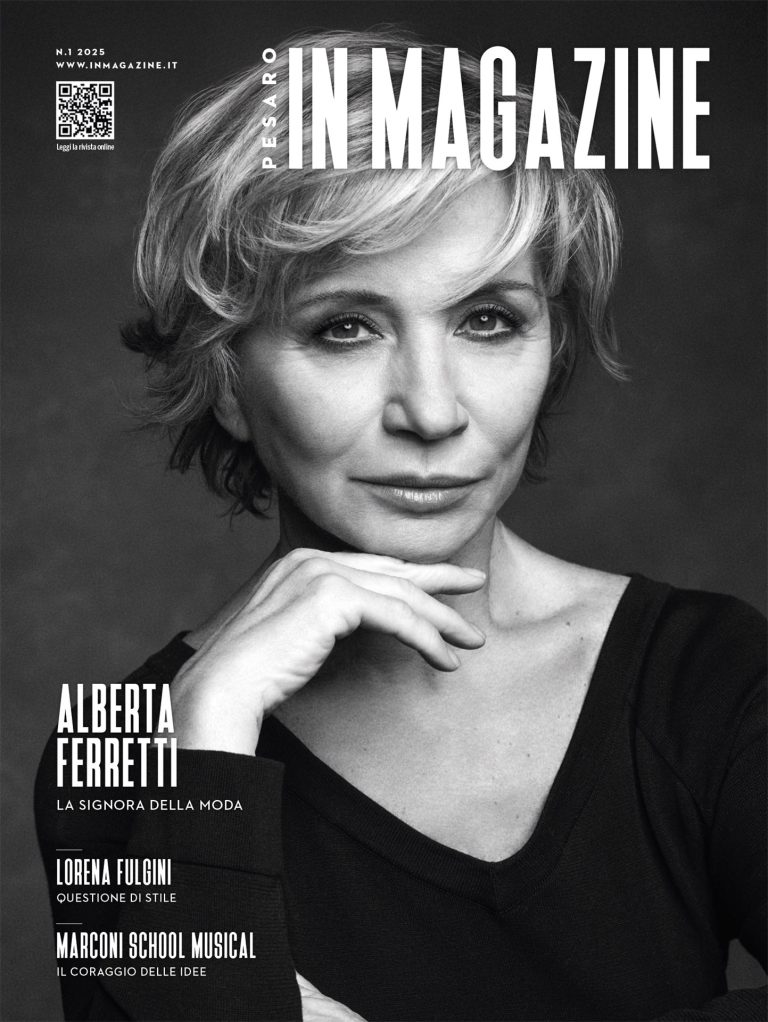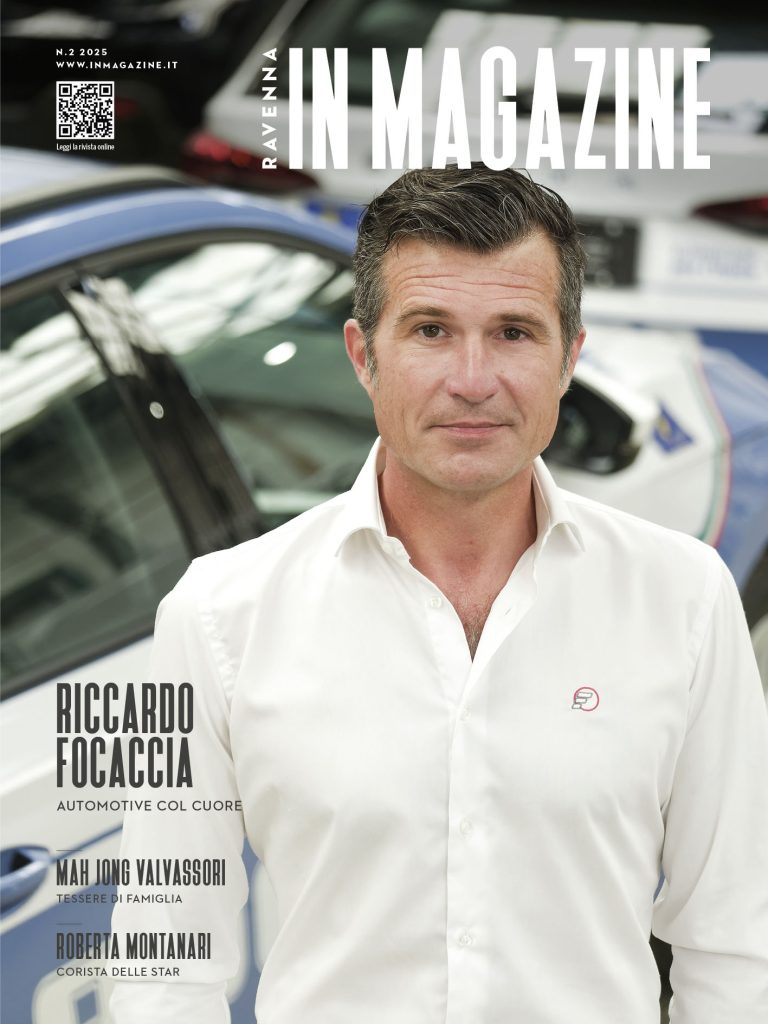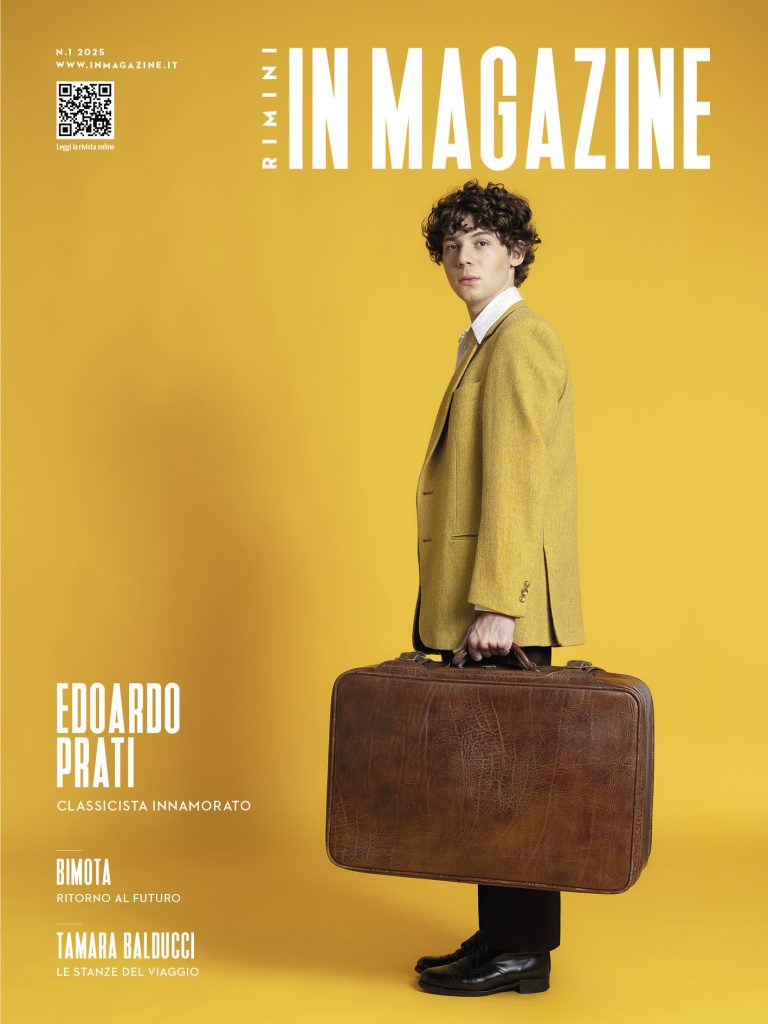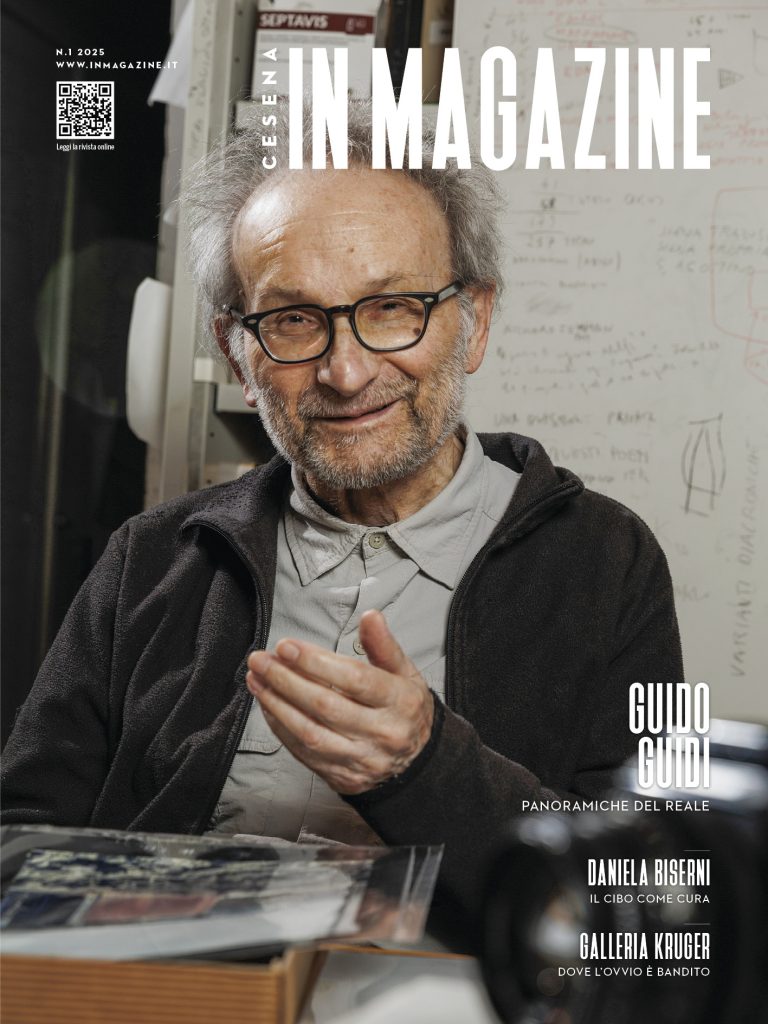I toni veementi con cui Benedetto Fiandrini, nella sua cronaca degli eventi cittadini del 1798, commentava la soppressione delle abbazie Ravenna di S. Apollinare in Classe, S. Vitale, S. Maria in Porto e S. Giovanni Evangelista, decretata dal governo giacobino, erano più che comprensibili. Essendo egli stesso un monaco di S. Vitale. Tuttavia, al di là della sua vicenda personale, erano anche oggettivamente fondati. Per quasi mille anni le quattro grandi abbazie erano state uno dei pilastri della vita non solo religiosa, ma anche economica, sociale e culturale di Ravenna. E difatti, il segno lasciato nella storia della città da queste istituzioni fu tanto profondo che la loro eredità è tuttora ben tangibile, soprattutto sul piano architettonico e ambientale.
Quella delle quattro abbazie Ravenna era una vicenda che affondava le sue radici nell’alto Medioevo. A Classe, ad esempio, l’esistenza di un monastero benedettino è attestata già nell’VIII secolo, anche se una svolta fondamentale si ebbe nel 1138 con l’affidamento ai Camaldolesi, l’ordine fondato circa un secolo prima dal ravennate san Romualdo.
Quello di Classe fu un esempio classico (si perdoni il gioco di parole) di fondazione monastica, che prevedeva un ascetico isolamento in un contesto separato dal consorzio umano. In deroga a questo principio esistevano però anche monasteri collocati all’interno delle città.
Si spiega così il fatto che, a partire dal X secolo, abbiamo notizia dell’esistenza delle comunità monastiche di S. Vitale e di S. Giovanni Evangelista, entrambe appartenenti all’ordine benedettino. Del tutto peculiare fu poi la vicenda di S. Maria in Porto Fuori, la chiesa fondata nel XII secolo sul luogo della miracolosa comparsa dell’immagine della Madonna Greca da Pietro Peccatore, che poi vi fondò una comunità di canonici denominati appunto Portuensi.
Naturalmente, le quattro abbazie Ravenna non erano le uniche della Ravenna medievale. Furono però quelle che, anche grazie al sostegno di papi, imperatori e arcivescovi, emersero col tempo come le più ricche e potenti.
Grazie all’assorbimento di monasteri minori, alle donazioni dei cittadini e all’oculata gestione economica accumularono patrimoni fondiari assai vasti: Classe, ad esempio, aveva possedimenti soprattutto nel territorio a sud della città, S. Vitale a nord, S. Giovanni Evangelista nel ferrarese e nel cervese, S. Maria in Porto a sud e a ovest.
Questa prima fase di gloria cominciò a incrinarsi a partire dal Duecento, quando anche le abbazie ravennati furono investite dal generale stato di crisi in cui cadde in quei secoli il monachesimo europeo. Fu in tale contesto che, soprattutto nel Quattrocento, furono oggetto di azioni di riforma che spesso portarono anche a un mutamento degli ordini affidatari: i Portuensi, ad esempio, si fusero con un’altra congregazione dando vita a quella dei canonici Lateranensi.
Fu però con la svolta del Cinquecento, in concomitanza col ritorno di Ravenna sotto la dominazione pontificia dopo la parentesi veneziana, che iniziò per loro una nuova età d’oro. Questo rinnovato prestigio si concretizzò innanzitutto in un grande fervore architettonico, che coinvolse in primo luogo i due monasteri extraurbani.
Sia Porto sia Classe, infatti, abbandonarono la loro isolata e insalubre collocazione originaria per costruire nuove e prestigiose sedi in città. I lateranensi iniziarono allora a edificare il palazzo della Loggetta Lombardesca e poi la grande chiesa adiacente, mentre i camaldolesi diedero il via al cantiere che nel corso dei secoli, con successive aggiunte, avrebbe costituito l’attuale complesso della biblioteca Classense. Ma anche i due monasteri già esistenti furono ricostruiti in forme rinascimentali.
L’imponenza architettonica dei nuovi edifici era lo specchio del ruolo sempre più dominante che le abbazie rivestivano nella vita della città. Accanto alle vaste tenute agricole, fin dal Medioevo esse erano usufruttuarie (di fatto proprietarie) anche delle pinete, che si impegnarono a valorizzare e ad estendere. Tanto che alla fine del Settecento la fascia boschiva, divisa in successione nord-sud nelle quattro pinete di S. Vitale, Porto, Classe e S. Giovanni, procedeva ininterrotta dal Lamone al Savio.
Esse erano inoltre uno dei fulcri della vita culturale della città. Classe, fra il Seicento e il Settecento, era probabilmente quella di maggior prestigio in questo senso. Grazie all’opera dell’abate Pietro Canneti che vi fondò l’accademia dei Concordi e vi edificò la sontuosa Libreria. Ma anche S. Vitale annoverò la presenza dell’abate Pietro Paolo Ginanni, storico ed erudito settecentesco, e alla fine di quel secolo fu sede di un importante museo medico-chirurgico.
Alla luce di tutto questo ben si spiega il trauma che percorse la città quando, quel 21 agosto 1798, i delegati del governo giacobino si presentarono alle porte dei quattro monasteri con il decreto che intimava agli ultimi occupanti di sgomberarli e ne incamerava i beni nella casse pubbliche.
Negli anni seguenti il destino che li attendeva sarebbe stato molto diverso. Il più fortunato fu quello di Classe, dove il Comune accentrò le istituzioni culturali cittadine, compresa la biblioteca che vi ha sede ancor oggi.
Il più infelice fu invece quello di S. Giovanni Evangelista, di cui resta solo un moncone perché fu in parte immediatamente smantellato, e poi ulteriormente danneggiato dai bombardamenti del 1944. S. Vitale e S. Maria in Porto furono a lungo adibiti a caserma, per poi trovare una degna destinazione rispettivamente come sede del Museo Nazionale e del Museo d’Arte.
Quanto alle pinete, cadute sotto la mannaia ‘bonificatrice’ quelle di Porto e di S. Giovanni, restano quelle di Classe e di S. Vitale a perpetuare la memoria dei monaci che tanta parte hanno avuto nel corso di mille anni di storia ravennate.