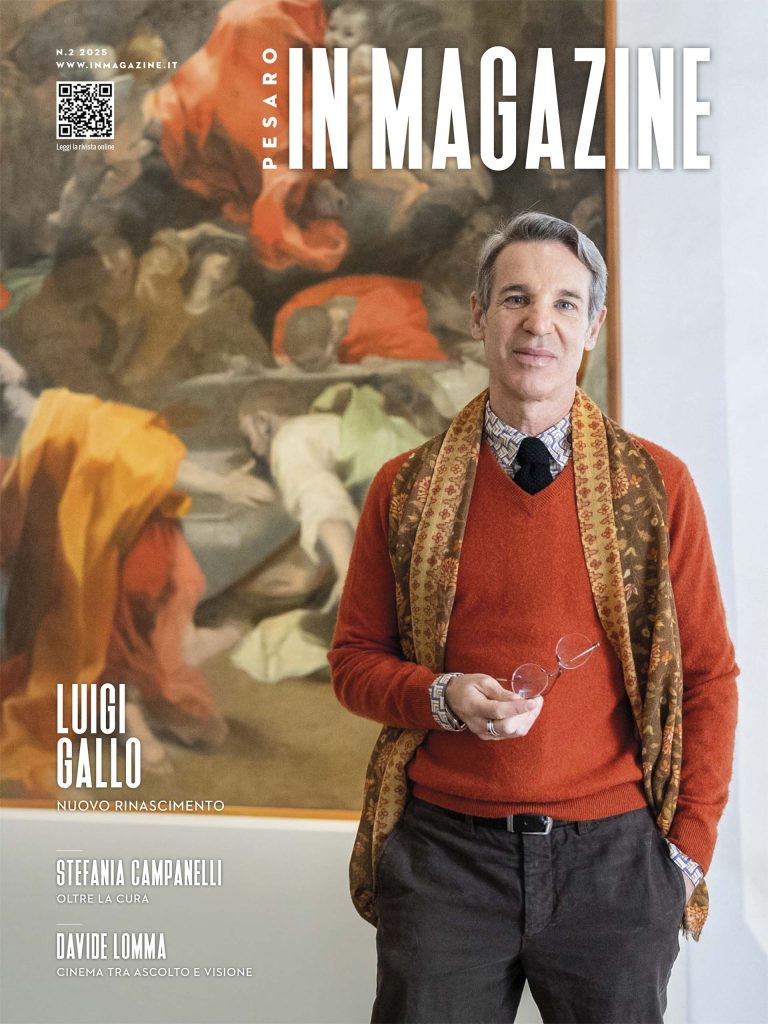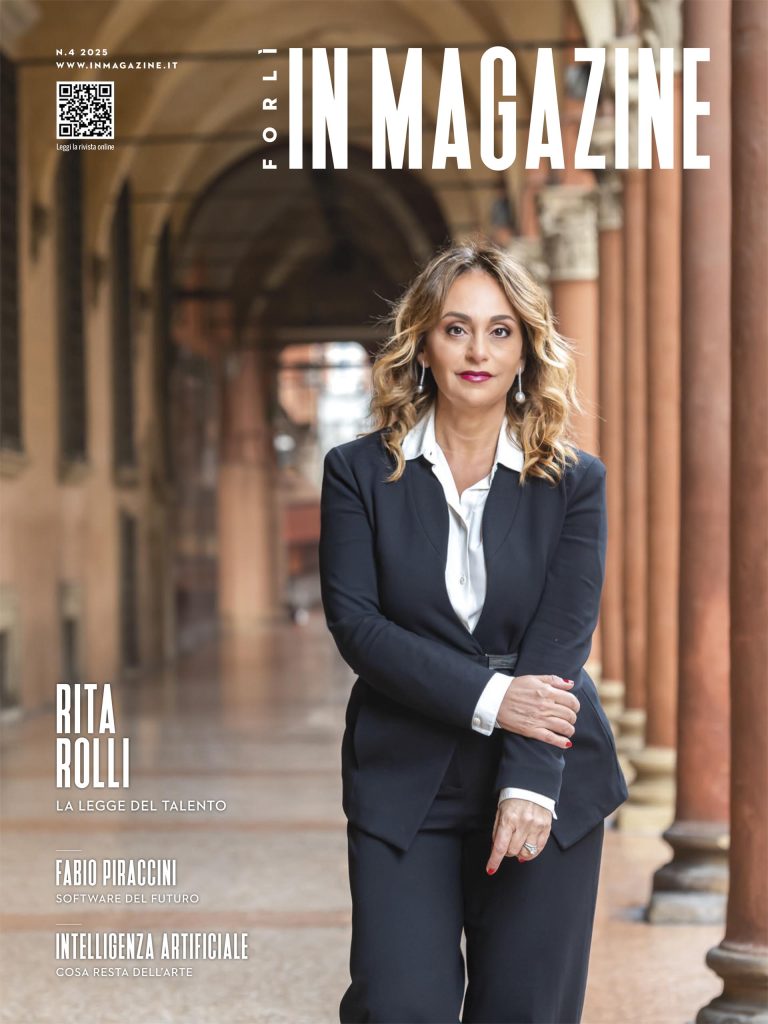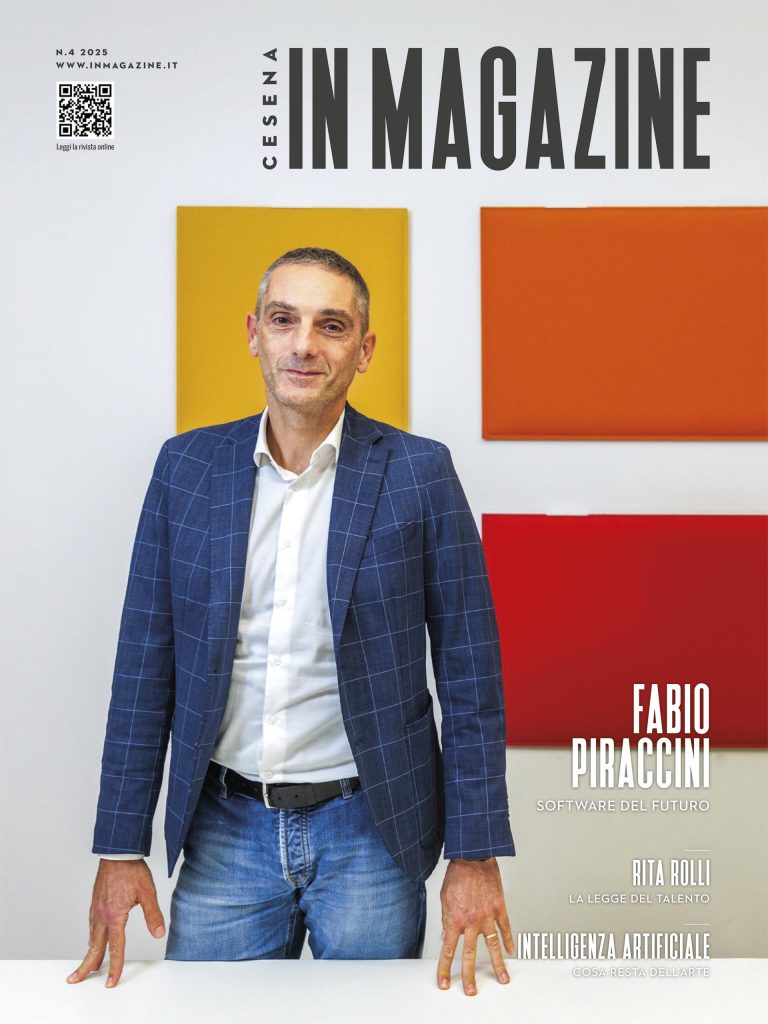A Caltagirone, Rosetta Berardi aveva studiato fino al diploma al liceo artistico. A Ravenna collabora in uno studio d’ingegneria, frequenta l’Accademia di Belle Arti e come spesso succede l’arte e la vita si confondono. Il modo di vivere in cui opera oggi è improntato all’attenzione dell’arte e dei libri. Nella casa editrice di cui si occupa, cura quella parte che può avere un rapporto con l’arte.
Gli anni dell’Accademia sono stati molto entusiasmanti per il bel rapporto con gli insegnanti. In particolare con il maestro Umberto Folli, un artista legato alla tradizione della ‘buona’ pittura aggiornata in versione espressionista. Rosetta Berardi dipingeva molto dal vero ed era brava a fare ritratti tanto che le è rimasta una particolare disposizione all’astrazione fisionomica.
In quegli anni, a Ravenna, le mostre proposte da Giulio Guberti alla Loggetta Lombardesca erano in aperta contrapposizione con l’insegnamento di Storia dell’arte da parte del professor Raffaele De Grada. Nasce quindi la necessità di frequentare il Dams per comprendere meglio l’arte contemporanea.
Per tutto il periodo dell’università non ha dipinto. Solo alla conclusione, dopo la laurea in Storia dell’Arte contemporanea con Piergiovanni Castagnoli, Rosetta Berardi riprende a dipingere. Si ritrova completamente diversa poiché la preparazione in accademia non corrispondeva più ai nuovi interessi.
Ha intrattenuto un’intensa amicizia e assidua frequentazione con Giulio Guberti. Ma la lezione di Folli era sempre presente, perché il rigore e la sintesi formale delle sue opere derivavano dall’insegnamento di Folli. Fin da quegli anni i materiali hanno avuto un ruolo significativo nella sua ricerca. Sia le carte piegate e manipolate che la tela tarlatana unita al ferro. Materiali semplici e primari in grado di accogliere forme geometriche minimali o segni grafici decisamente concettuali.
Deve succedere un evento che la colpisca. Che la stimoli a creare opere che hanno a che fare con quell’evento vissuto, velato di dramma e dolore. L’incendio della pineta di Lido di Dante del 2012 l’ha coinvolta emotivamente. Qualche giorno dopo è andata a vedere quello che era rimasto. Veramente era un cimitero, e talmente forte era l’impressione che ha iniziato a lavorare sul tema della natura violata e tuttora continua a lavorarci.
Qualcuno le dice che queste opere ricordano l’Oriente, il Giappone, e in effetti utilizza un pennello giapponese. Nel suo soggiorno in Giappone ha infatti studiato l’arte giapponese, l’ikebana. E poiché ama l’essenzialità, è portata a riprodurre la natura non con uno sguardo descrittivo, ma tende piuttosto a ridurre l’aspetto coloristico al bianco e nero. Quando ricorre ai colori, usa quelli primari, rosso, blu e giallo sempre puliti senza sconfinamenti tonali.
Con l’avvento della macchina fotografica digitale ha avviato un’altra ricerca perché può utilizzare il mouse come fosse un pennello, anche per lavori di grandi dimensioni. Nel ciclo di opere fotografiche Dietro il volto. L’universale mistero del velo le fotografie, realizzate nell’arco di venti anni durante i viaggi in Turchia, India, Spagna e nel mondo arabo, sono state decontestualizzate, ha eliminato tutto quello che era attorno per rendere la figura monumentale e mettere in risalto i diversi modi in cui il velo viene portato.
Quando si è accorta, dopo anni, di aver fotografato tante donne velate riprese da dietro, Rosetta Berardi si è chiesta perché subiva questo fascino e, andando indietro nella memoria, ha ricordato che la nonna portava il velo per andare in chiesa e da bambina desiderava di poterlo indossare anche lei.
Un altro elemento che in questi Paesi ha attirato la sua attenzione è la scrittura che invadeva i muri delle città. Interessata, impegnata per una serie di dipinti calligrafici che raffigurano lettere cinesi, indiane e arabe come ‘tracce della memoria’. Queste opere sono state esposte per la prima volta a Parigi nella sede dell’Unesco dove è stata invitata per una mostra personale a rappresentare l’Italia nella Giornata Internazionale della donna, l’8 marzo 2007.
L’ideogramma ha una valenza concettuale, perché altro non è che la rappresentazione grafica di un concetto e, come tale, comporta una visione poetica del reale rivissuto interiormente. Già Giorgio Bonomi, sul finire del secolo scorso, avvertiva come nelle ricerche della Berardi sopravvivesse “un senso tragico del tempo e della vita, ora in modo esplicito ora in modo allusivo e simbolico […] con tutti i rimandi di nostalgia, tristezza, di interrogativi che lo scorrere del tempo implica.”
Una sensibilità poetica che attraversa l’intera produzione di Rosetta Berardi, come sintetizza il titolo della recente retrospettiva a Palazzo Rasponi delle Teste, Iconografie del dolore privato. Dolore che, nella conclusione del testo in catalogo di Linda Kniffitz, “da manifestazione introspettiva e solitaria diviene testimonianza e metafora di una condizione che coinvolge realmente e strettamente l’umanità intera.”