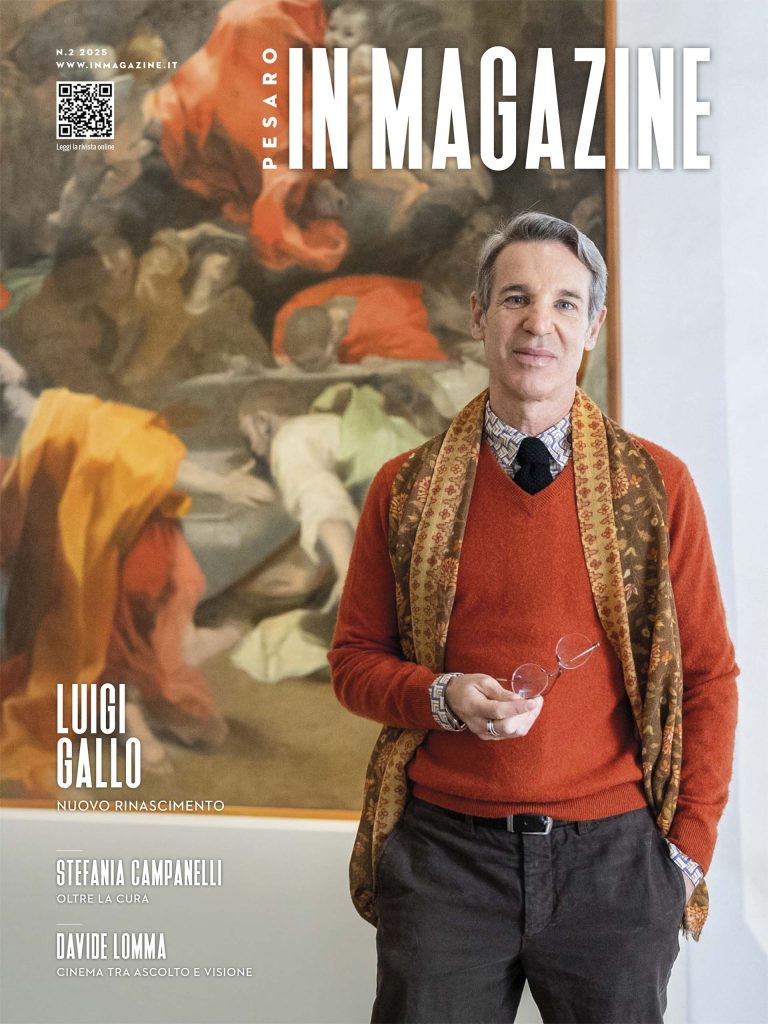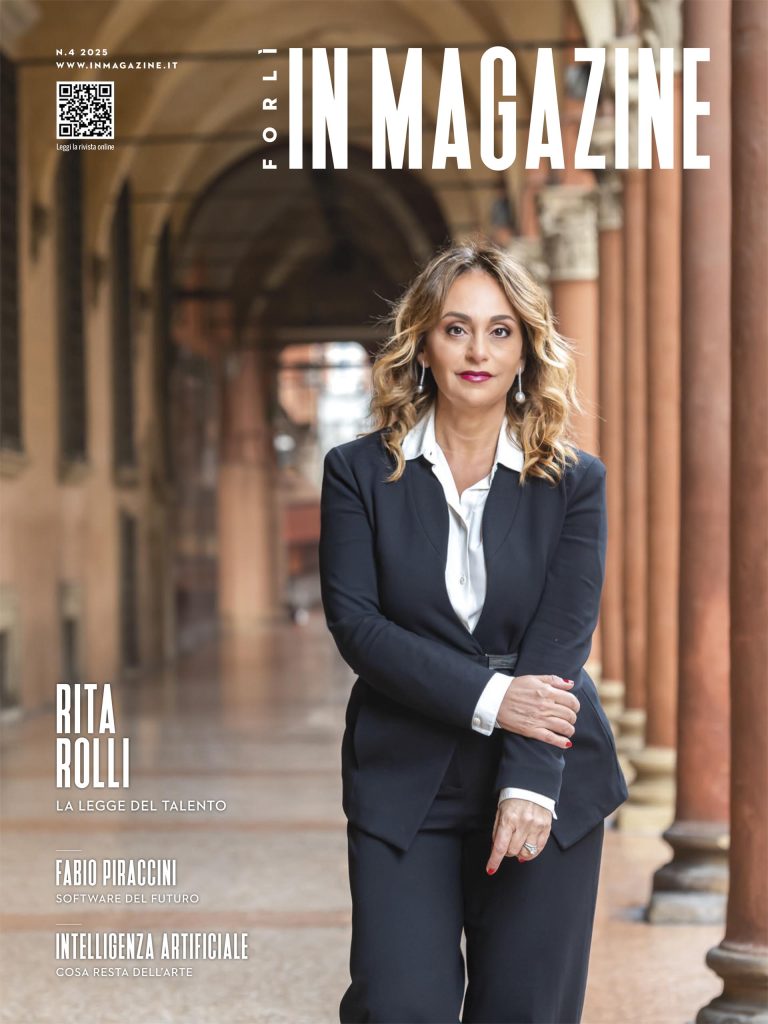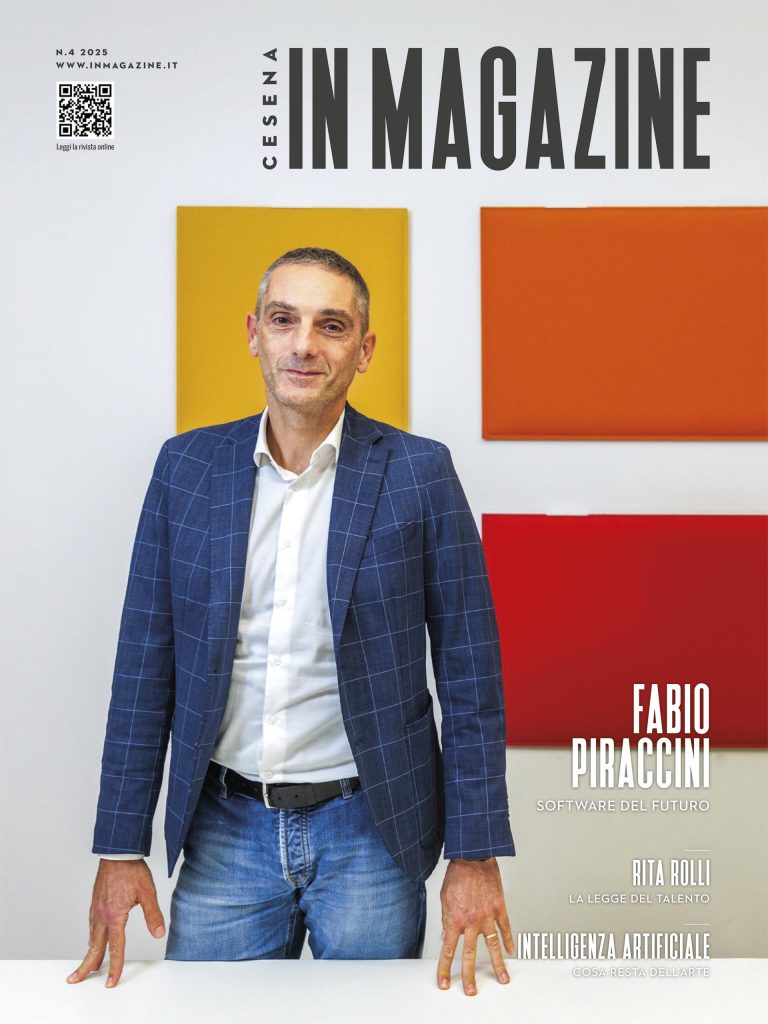La storia della Sarom è strettamente legata a quella del suo fondatore, la cui figura è a sua volta assai emblematica nell’incarnare due caratteristiche peculiari del capitalismo italiano. Un notevole talento imprenditoriale e una spregiudicata capacità di intrecciare proficue relazioni con il potere politico.
Figlio di un fabbro del borgo S. Biagio, ma anche amico e sodale di Ettore Muti. Monti poté senza dubbio contare sull’appoggio del più carismatico dei gerarchi ravennati allorquando, nel 1938, ottenne dal governo l’iscrizione nell’elenco degli importatori di petrolio. Era, questa, la premessa indispensabile per la sua prima consistente iniziativa imprenditoriale. E cioè la costruzione di un deposito di prodotti petroliferi raffinati, realizzata nel giro di un paio d’anni sulle rive del Candiano.
Passata la guerra e sanate le sue distruzioni, Monti fu abile nell’intuire la direzione che avrebbe preso il commercio del petrolio nel nuovo contesto dell’economia postbellica. Non più l’importazione del prodotto finito, ma la lavorazione del greggio che sarebbe affluito in quantità sempre più consistente dal Medio Oriente.
Fu così che, nel maggio del 1950, costituì la sua nuova creatura. La Società Anonima Raffinazione Oli Minerali (Sarom), appunto con l’obiettivo di trasformare il deposito in una moderna raffineria. Ottenuto l’appoggio del Partito Repubblicano, che reggeva l’amministrazione della città, poté quindi procedere velocemente alla costruzione del nuovo stabilimento. Entrato poi in funzione alla fine del 1951.
Era proprio il momento giusto per intercettare le enormi potenzialità dell’incipiente boom economico. E in particolare l’esplosione della motorizzazione di massa, che non aspettava altro che alimentarsi anche della benzina commercializzata da Ravenna con il marchio Sarom 99.
Alla metà degli anni Cinquanta, forte anche di un rapporto privilegiato con la British Petroleum, Monti era già diventato uno dei più importanti petrolieri italiani. Insieme ai Moratti e ai Garrone. Simbolo di questa ascesa nel gotha dell’imprenditoria nazionale fu l’avveniristico grattacielo costruito a Milano come sede della società, la Torre Galfa, inaugurata nel 1959.
A Ravenna, l’immagine più iconica fu invece quella della cosiddetta ‘isola d’acciaio’. Il terminale di attracco per le petroliere realizzato nel 1956 al largo di Porto Corsini. La data era significativa. In quegli stessi mesi, sulla sponda opposta del Candiano, fervevano infatti i lavori per la costruzione dell’altro grande stabilimento, quello dell’Anic. Insieme alla Sarom divenne l’emblema della poderosa trasformazione che fece di Ravenna una delle città simbolo del nuovo sviluppo industriale italiano. E della sua idea di modernità.
Una modernità fatta di torri fumanti e di castelli d’acciaio. Di luci perenni e di schiere di operai che affollavano quelle che, fino a pochi anni prima, erano paludi solitarie o silenziose pinete.
Ma non era tutto. Oltre che sul piano economico, l’azienda di Monti lasciò un segno tangibile della sua presenza anche nel più generale contesto della vita sociale della città. Per esempio nello sport. Nel 1955, insieme al ‘Pedale Ravennate’, l’azienda organizzò l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia. La cronometro Cervia-Ravenna vinta da Fontana davanti a Coppi e a Magni.
Ma già l’anno precedente Monti aveva acquistato la società di calcio cittadina, affidandone la presidenza al direttore della Sarom, Gino Guccerelli. Ribattezzata appunto con il nome di Sarom Ravenna, nei primi anni la squadra conobbe una rapida ascesa. Fino a sfiorare la promozione in serie B nel 1958.
Proprio la cessione della società calcistica qualche anno dopo, nel 1964, fu però il segno che qualcosa nel rapporto con la città (e con i suoi nuovi equilibri politici) si era rotto. Non che l’attività della raffineria fosse in crisi. All’inizio degli anni Settanta, anzi, la Sarom era al suo apogeo. Ma proprio in quel momento la crisi petrolifera del 1973 le sferrò un colpo che ne avrebbe causato la caduta. Tanto repentina quanto rapida era stata l’ascesa di vent’anni prima.
A quel punto si rivelò provvidenziale un’operazione che Monti aveva effettuato già nel 1966. E cioè l’acquisto dell’Eridania, azienda leader nel mercato italiano dello zucchero, e che a sua volta deteneva il controllo di alcuni importanti quotidiani. In particolare Il Resto del Carlino, ma anche La Nazione e altre testate in tutto il territorio nazionale.
Dagli anni Ottanta il gruppo Monti (oggi Monrif, denominazione che rimanda anche al nome del genero e socio del fondatore, Bruno Riffeser) precisò sempre più la propria identità come holding nel campo editoriale, nel quale tuttora ricopre una posizione di punta.
Intanto, nel 1979, l’Eridania era stata ceduta a Serafino Ferruzzi, in quello che è impossibile non vedere come un simbolico passaggio di consegne fra i due gruppi che hanno fatto la storia di Ravenna del secondo Novecento.
E la Sarom? Ormai in crisi irreversibile, la società venne acquisita nel 1981 dall’Eni, che quattro anni dopo chiuse definitivamente i battenti della raffineria. Dopo essere tornato per qualche tempo un semplice deposito di carburante, a sua volta chiuso nel 1993 (un anno prima della morte di Monti, da tempo residente in Francia), lo stabilimento venne infine smantellato.
Svanito il progetto di realizzare nel sito un polo della nautica, con il tempo è stata la natura a riprendere il sopravvento. Con la foresta spontanea cresciuta in straniante contrasto con i due ultimi manufatti superstiti della vecchia raffineria, le due grandi torri di cemento sulle quali un tempo campeggiava il marchio della società.
Con il loro abbattimento da parte dell’Autorità portuale, attuale proprietaria dell’area, al fine della realizzazione di un parco fotovoltaico, nella primavera del 2024 anche questa pagina di storia ravennate si è chiusa per sempre.