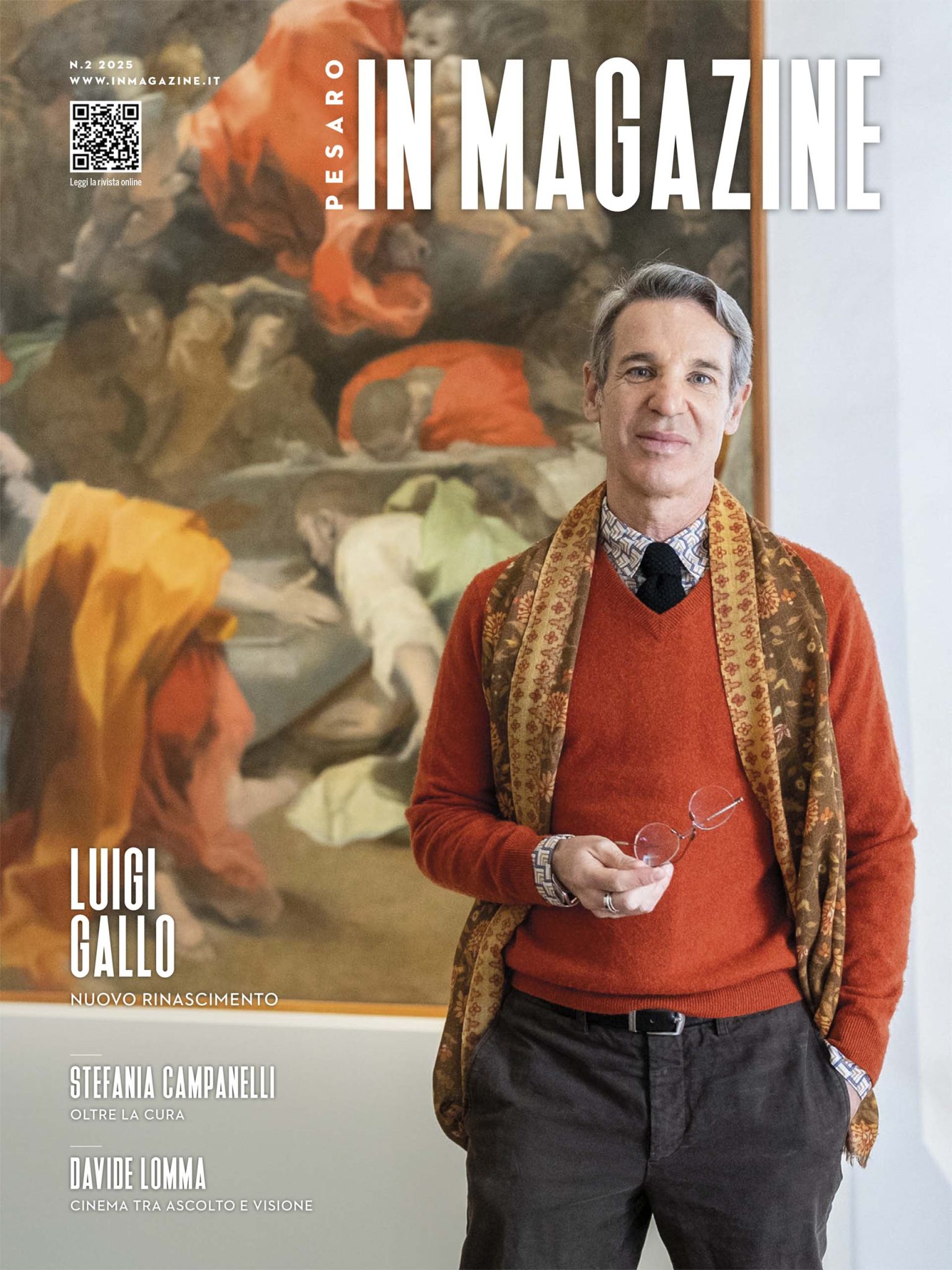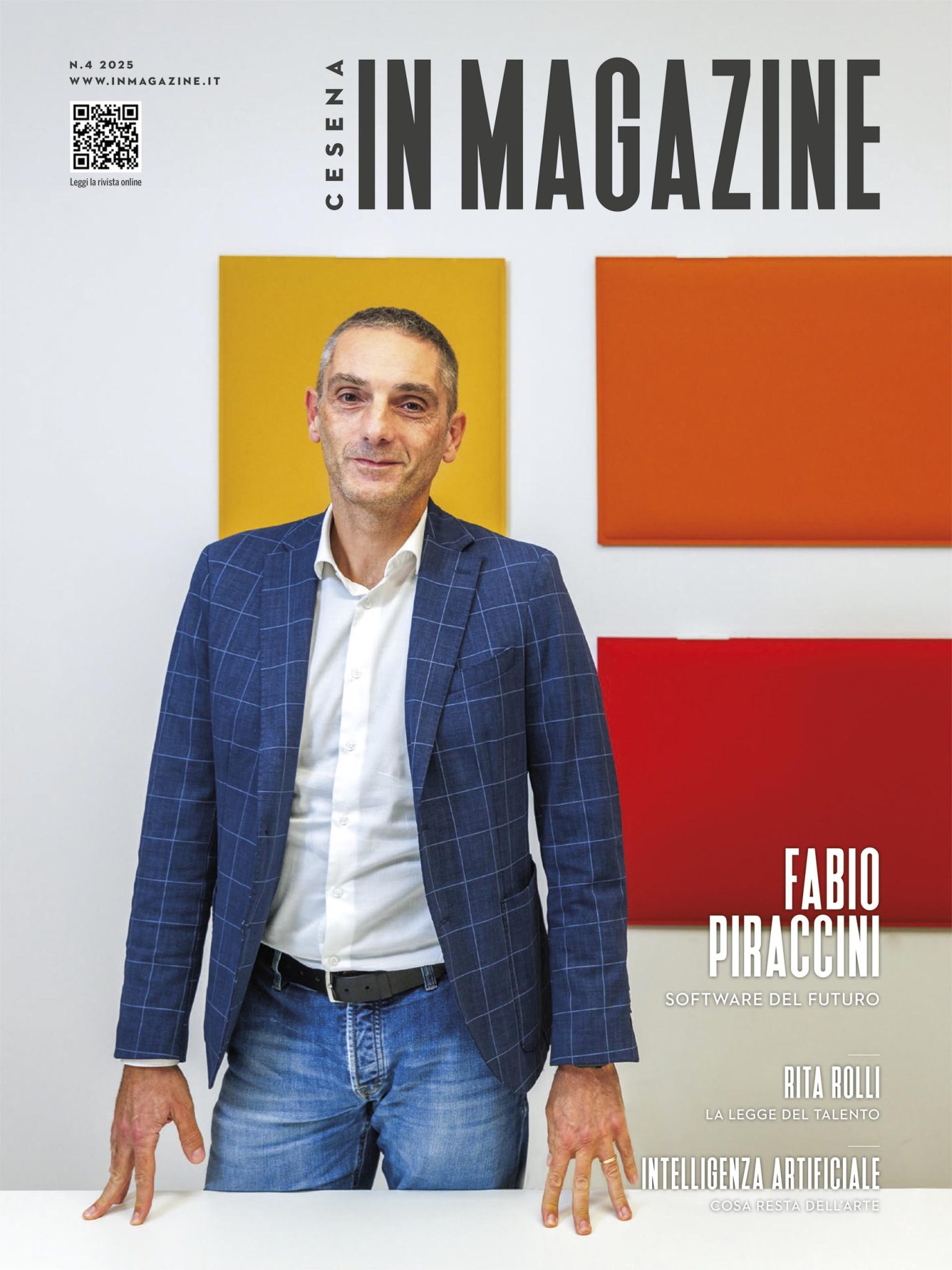Precipitano a valle proprio come le prime acque del fiume Conca. Complice la morfologia del terreno, inizia qui tra le sorgive del monte il suo cammino che, in una cinquantina di chilometri scarsi, lo porterà verso il mare. Sulla sommità l’eremo della Madonna del Faggio, dove da tempo immemorabile si venera la Beata Vergine.
A poca distanza dall’eremo, un sentiero si inoltra nel bosco di abeti e faggi fino a incontrare il primo tratto del fiume. Che, raccolte le prime acque dalle sorgive, inizia anche in modo vigoroso la sua corsa verso valle.
Oltrepassate le prime case, per incontrarlo nuovamente bisognerà raggiungere il fiume all’altezza di Caprile. Qui, a qualche centinaio di metri dal ponte Conca sulla provinciale che lega Villagrande a Carpegna, si può ammirare lo spettacolare salto del fiume con le sue cascatelle. Sono solo una ventina di metri (forse) ma di grande suggestione, specie quando la stagione favorisce con le piogge il flusso delle acque.
Più che a seguirne il corso, le strade percorribili lo tagliano e rendono quasi impossibile godere da vicino della bellezza del fiume. Con un paio di eccezioni legate alla viabilità minore, bisognerà dunque giungere fino a Monte Cerignone per tentare l’inizio di un viaggio in comunione. Nella difficoltà accontentiamoci delle bellezze della storia e anche delle storie.
Monte Cerignone, appunto, col suo borgo quasi immacolato che si erge con la sua rocca su un alto costone di tufo. Un profilo che è riuscito a incantare anche Umberto Eco che qui, dopo un fortuito incontro, prese casa – una casa padronale appartenuta anche ai Gesuiti – eleggendo il luogo a buen retiro.
Fu qui che, immerso nella tranquilla atmosfera di un luogo senza tempo sembra – ‘sembra’ è d’obbligo – sia nato Il nome della rosa. Tradotto in più di 40 lingue e venduto in oltre di 50 milioni di copie in tutto il mondo.
Con Monte Cerignone inizia un susseguirsi di piccoli borghi sull’altura che dall’alto della sponda di sinistra seguono il fiume. Tutti contrassegnati dal toponimo ‘monte’, quasi a evidenziarne il ruolo. Monte Grimano, ad esempio, ma anche Montescudo o Monte Colombo. O, magnificenza tra le magnificenze, Montefiore Conca che, con il suo castello imperioso, è visibile da lunga distanza.
Lungo tutto il suo percorso il fiume Conca ha continuato ad alimentare un gran numero di ‘fosse’. Quei canali artificiali paralleli al fiume utilizzati, oltre che per irrigare i campi, per attivare i mulini. I toponimi ancora presenti sul territorio non lasciano dubbi. Ed è certo che nel 1662 fossero ben 66 i mulini alimentati dal Conca per un’attività fondamentale dell’economia del riminese proseguita fino al secolo scorso.
Ormai, dell’originario torrente che abbiamo iniziato a seguire più a monte non vi è traccia e quello che, raggiunta Morciano, scorre verso il mare, è un fiume ampio e – nella stagione propizia – ricco d’acqua, capace di alimentare l’attività dell’uomo, con le acque raccolte nel bacino del Conca poco prima della foce, ma anche di rovinose piene.
‘Crustumium rapax’ aveva definito il fiume il poeta romano Lucano poco meno di 2000 anni fa, evidenziandone il carattere distruttivo, rapace. Sì Crustumium, dall’antico nome latino del fiume che, come altri, per cause ancora non definite già prima dell’VIII sec. cambiò denominazione in Conca, proprio come l’Ariminus divenne il Marecchia e il Pisaurus il Foglia.
In prossimità del moderno complesso turistico di Porto Verde, il viaggio è in procinto di finire, ma non le emozioni che l’hanno accompagnato. Anzi, ecco, sono proprio là dove le acque del fiume e del mare si intrecciano con un ultimo regalo.
“Sotto Focara, verso Rimini, vi è un vico chiamato Cattolica presso il quale – quando il mare è tranquillo – si vedono sott’acqua le tracce di mura e di torri di una città inghiottita dal mare e che era chiamata Conca.”
Sono le parole lasciateci dallo storico e umanista italiano del Rinascimento Flavio Biondo di Forlì attorno alla metà del 1400, riprese anche dall’Adimari, dal Cimarelli e, nei secoli, da una quantità considerevole di studiosi tra cui nell’Ottocento, pur senza convinzione, il Tonini. Una nuova ‘Atlantide’? Anche se oggi sappiamo che quasi certamente non è così, continuiamo a sognare ancor un po’.