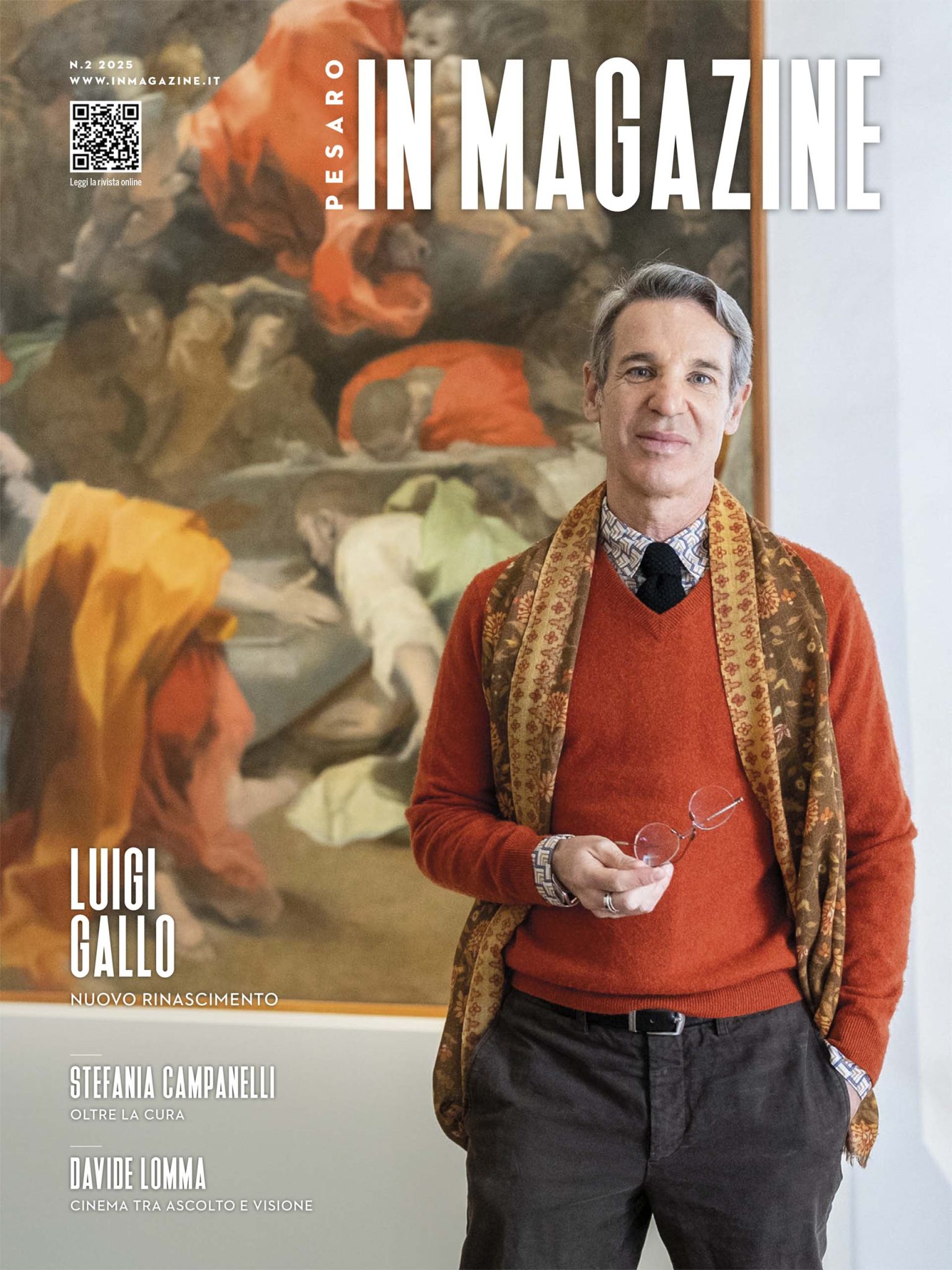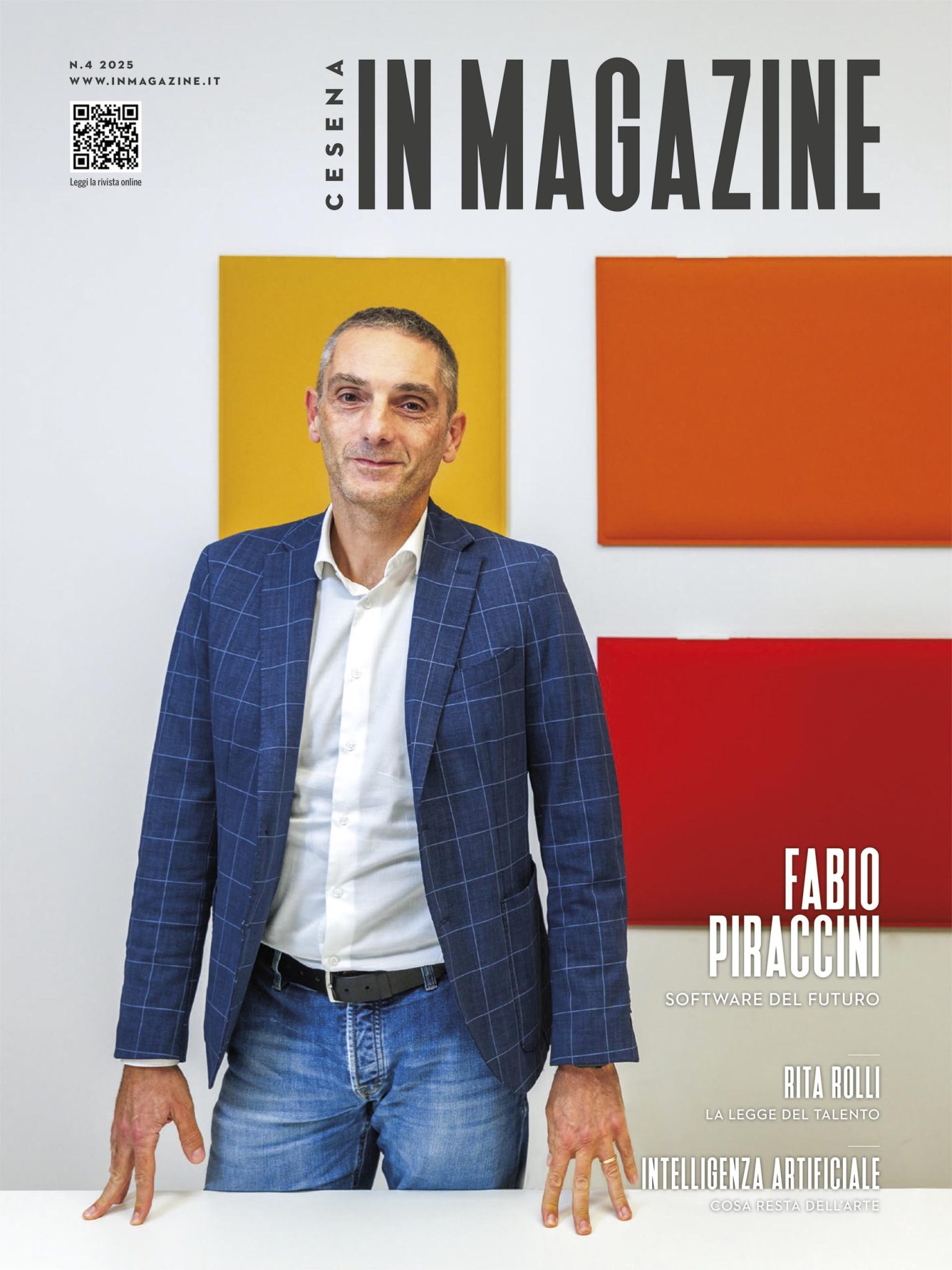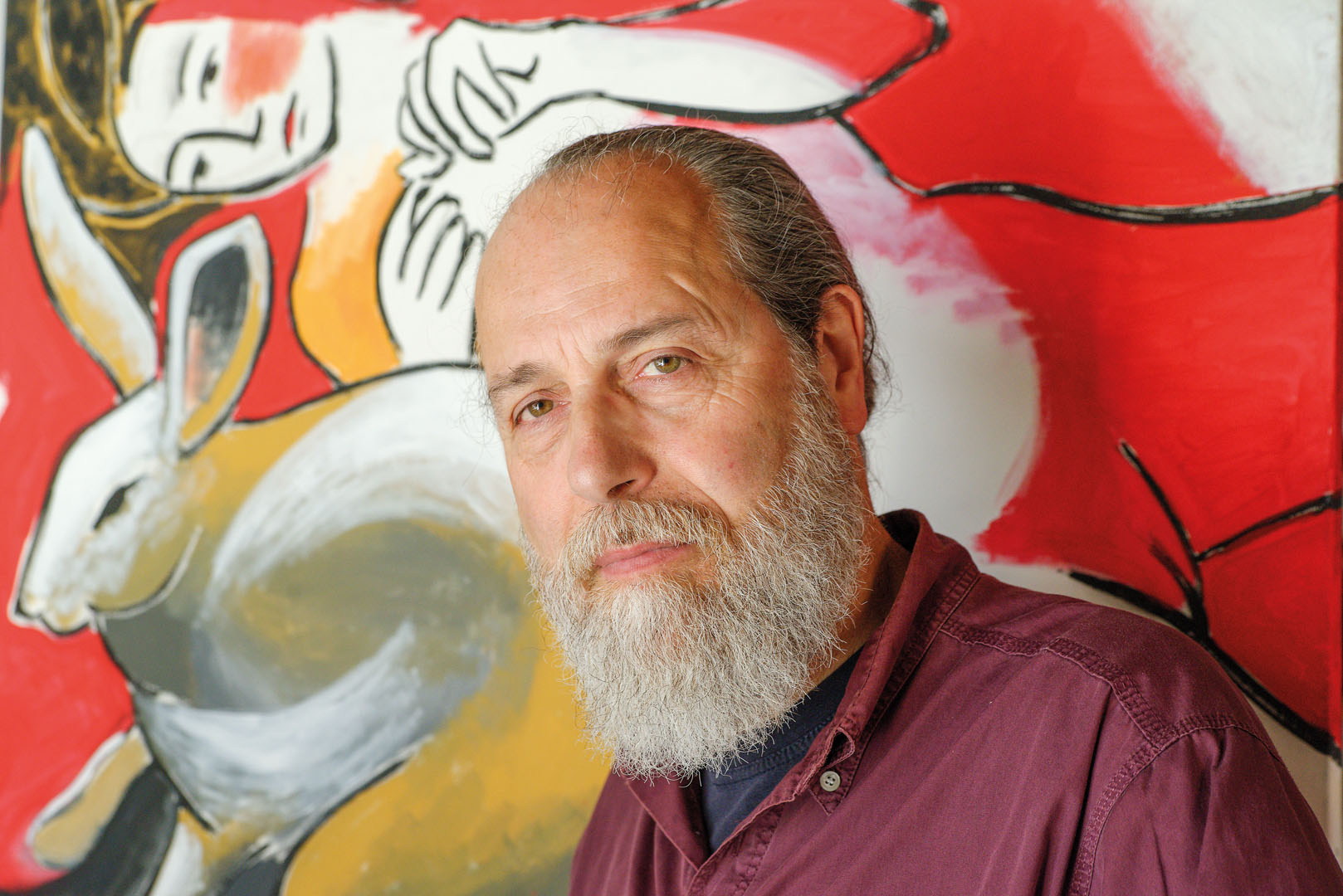Il Cimitero Monumentale di Forlì è una vera e propria grande città con strade, alberi, mura. Recentemente, la vasta città dei morti è stata riscoperta pure come attrazione turistica. Con visite guidate anche al tramonto, in momenti in cui l’accesso ai vivi è di norma precluso, regalando suggestioni ancora più forti.
Se il quadrilatero si può considerare il ‘centro storico’ del camposanto ottocentesco, si estende pure una periferia oltre la prima cerchia muraria. Periferia inizialmente un po’ disordinata. Con vialetti stretti coperti di ghiaia accanto a sepolcri più recenti e tempietti simili a villette secondo gusti e risorse delle famiglie.
Oltre a questa fascia se n’estende un’altra ancor più moderna, alternata a verde con panchine e dove incombono i loculi su strutture a più piani. E ancora, verso il mare, si estende un fazzoletto ancora verde, destinato ai morituri, e l’area dei sepolti a terra. Con croci provvisorie, in legno e segni d’affetto e di pietà dei familiari.
Si possono leggere nomi e dettagli che abbracciano varie vicende vicine e lontane della città. Dalle iscrizioni in lapidi ormai sbiadite, a nomi cinesi e di qualche altro Paese lontano. Per esempio dai Balcani, con bottiglie di birra accanto ai loculi a ristoro di un caro estinto.
Vale poi segnarsi il compendio di nomi misteriosi e creativi. Come Celide, Fiovo, Presentino, Amalfisa, Sferica, Ilvano, Eviardo (solo per fare qualche esempio): fanno rivivere tempi di scarso conformismo. Alle croci, si alternano squadre e compassi, stelle, foglie d’edera, mezzelune, e altri simboli che rendono esplicita la fede del defunto.
Il Monumentale, dunque, vive e muta nel tempo pur mantenendo il silenzio e quel distacco severo e sacro proprio del trapasso. Frutto di una serie pluridecennale di progetti discussi, rinviati, modificati (quello definitivo porta la data del 1867), fu completato vent’anni più tardi. Almeno nella sua forma originaria. Un quadrato perfetto di 140 metri per lato delimita il perimetro originario, quello confinato dal solenne porticato, che trova il suo culmine nel Pantheon o Famedio dei forlivesi.
Costruito a metà del lato settentrionale, sul modello dei templi corinzi, è abbracciato da portici sopraelevati le cui arcate forniscono alle famiglie notabili cappelle e tombe, per distinguersi da quelle del ‘piano terra’. Nei portici rifulgono vestigia di una nobiltà che non mostra parsimonia ma neppure indulge sullo sfarzo.
L’umidità sbriciola l’intonaco, ricordando sì la caducità, ma anche la necessità di qualche lavoro per recuperare decoro. Sono tombe composte e sobrie benché ricche, ferme nel tempo, antidoto contro la mortalità. Un boschetto selvaggio nasconde la tomba sotterranea di Aurelio Saffi, corredata di resti romani. Le lapidi antiche e abbandonate, dalle suggestioni gotiche e floreali, sono sostitute a via a via da cappelline marmoree con fotografie a colori. Perché la storia del luogo dei morti è in continuo divenire.
Forlì già di per sé dovrebbe essere la città con il maggior numero di camposanti: sono ben 38, di cui 31 parrocchiali e 7 comunali. Davanti al Cimitero Monumentale, dal dicembre del 1944 si estende il Cimitero di Guerra Indiano. Qui riposano centinaia di ‘soldati col turbante’ inquadrati nell’Ottava armata britannica, di religione Sikh.
Sono 496 i giovani sepolti, di cui 15 senza nome. Altri sono ricordati in un monumento commemorativo mentre un gruppo scultoreo in bronzo collocato nel 2011 ricorda questi ragazzi venuti da lontano per contribuire a liberare la Romagna.
L’altro cimitero di guerra è a Vecchiazzano, in via Borghina. Vi sono sepolti 738 caduti della Seconda Guerra Mondiale, di cui 4 sono ancora ignoti. Si tratta di soldati inglesi, canadesi, neozelandesi, sudafricani, indiani, del ‘Pioner Corps’ dell’Africa del Sud e delle Seychelles che caddero nei combattimenti dell’ottobre-dicembre 1944, nella zona fra Rimini e Ravenna.